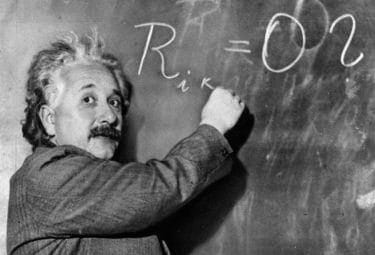«I nuovi programmi vietano le trite nozioni che per tanto tempo hanno aduggiato la scuola dei fanciulli; e richiedono la schietta poesia, la ingenua ricerca del vero, l’agile indagare dello spirito popolare, irrequieto e mai sazio di “perché”; il rapimento nella contemplazione dei quadri luminosi dell’arte e della vita; la comunicazione con le grandi anime, fatte vive e quasi presenti attraverso la parola del maestro (…). Se il maestro (…) sarà pedante ripetitore, la vita spirituale rifuggirà da lui e si manifesterà in quelle forme inconsapevolmente ma irreprimibilmente difensive proprie del fanciullo che sono la irrequietezza e la turbolenza».
È l’11 novembre 1923 e Giuseppe Lombardo Radice licenzia con questa premessa i “programmi” per la nuova scuola elementare. Tolto il lirismo d’antan, difficile non sottoscrivere. E difficile non considerare come, ieri e oggi, schiere di pedanti ripetitori abbiano visto “rifuggire” la vita spirituale e schiere, altrettanto nutrite, di corifei di una malintesa modernità, abbiano messo in soffitta i “quadri luminosi dell’arte” e seppellito le “grandi anime”. In mezzo, la falange di insegnati che, onestamente e umilmente, anno dopo anno, ha cercato di districarsi tra ordinanze, circolari, indicazioni, OSA, “assi”, competenze chiave e compiere al meglio la propria missione educativa e culturale.
Una parentesi appare necessaria. Ho avuto un ruolo non secondario nell’adozione dello schema europeo, fondata sul trinomio conoscenze, abilità, competenze, che sosterrà le future “indicazioni nazionali” liceali. E sono convinto che la certificazione delle competenze alla fine dell’obbligo formativo sia un atto dovuto e necessario, che non sostituisce ma integra la tradizionale “pagella”. Eppure non ho esitazione a schierarmi, nel mio piccolo, con Luciano Canfora ed Ernesto Galli della Loggia, Giorgio Israel e Paola Mastrocola. Nella pattuglia, tutt’altro che sparuta, di chi si rifiuta di sacrificare le conoscenze sull’altare delle competenze, per il semplice motivo che le seconde, senza le prime, semplicemente non sono. Ebbe a dire William Butler Yeats che «l’istruzione non è riempire un secchio, ma accendere un fuoco».
PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO, CLICCA IL SIMBOLO “>>” QUI SOTTO
A ben vedere, nella querelle tra competenzisti e contenutisti, tra teste piene e teste ben fatte (tra “tacchi alti e tacchi bassi”, direbbe Jonathan Swift) la frase rappresenta un brillante punto di sintesi. Perché, per accendere un fuoco, occorre per lo meno avere legna o altro materiale combustibile. Per costruire un edificio, occorrono mattoni. E un campo, senza semi, non dà frutti. Banale, vero? Talmente banale che gli storici “programmi ministeriali” per i licei redatti dalla Sotto commissione alleata nel 1944/1945, più volte idolo polemico del pedagogismo “a la page”, non facevano altro che elencare una serie di conoscenze ritenute fondamentali premettendo, liceo per liceo e disciplina per disciplina, una “declaratoria” che riassumeva – ma vedi il caso strano! – quelle che oggi definiremmo competenze in uscita.
Come dare torto a Giorgio Israel, quando asserisce «le competenze? Una cosa che abbiamo sempre fatto!». O, almeno e più realisticamente, «che si sarebbe dovuta fare» già da oltre sessant’anni. Colgo dal programma di italiano: «I due anni di biennio offrono al giovane la possibilità di impadronirsi, attraverso la conoscenza dei migliori autori, di un patrimonio che sarà ulteriormente approfondito nel triennio, e che intanto svilupperà in lui il gusto e la capacità dell’espressione aderente e sentita, e renderà consapevole il suo giudizio estetico (…). Della padronanza della nostra lingua, delle capacità di valutazione delle opere, della sensibilità nell’esame di processi naturali, moti dell’animo, concetti, daranno prova d’ora innanzi gli alunni in gare collettive per l’espressione precisa e bella, e nella redazione scritta individuale».
Segue dettaglio (per modo di dire: una paginetta) delle conoscenze fondamentali richieste. Un capolavoro ineguagliato di buon senso, perché il buon senso aveva guidato i redattori, tra i quali il pedagogista statunitense Carleton Wolsey Washburne. Il quale Washburne, dal canto suo, era teorizzatore e propugnatore di un particolare metodo didattico (praticato nel complesso scolastico sperimentale di Winnetka) che si era ben guardato, pur avendone la possibilità, di prescrivere a tutte le scuole italiane: perché i metodi didattici sono, per loro natura, plurali, diversificati, adattabili caso per caso. Non si impongono per circolare ministeriale, ma si propongono e si discutono nel dibattito tra gli insegnanti che dovrebbero testarne la validità avendo come unico fine il successo educativo.
PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO, CLICCA SUL SIMBOLO ">>" QUI SOTTO
Forse il difetto (imperdonabile!) di quelle declaratorie era di essere scritte in buon italiano (che magari oggi può apparire un poco polveroso, ma nulla più), di essere comprensibili e aliene dalle fumisterie e dalle “tecnicalità” che hanno funestato, nei decenni successivi, tanta parte della produzione “trasteverina”. Trasteverina, poi, per modo di dire. Perché gli incolpevoli funzionari e dirigenti del ministero dell’istruzione si trovavano costretti a mettere su carta le elucubrazioni dell’esperto di passaggio, con risultati a volte grotteschi: per limitarci alle indicazioni nazionali del 226/2005, alla voce «obiettivi specifici di apprendimento di lingua italiana nel biennio dei licei», cosa diavolo rappresenti «l’uso consapevole della scrittura veloce e compendiata» o «padroneggiare in particolare il dinamismo del verbo come generatore della struttura della frase e compiere trasformazioni in tale struttura» è materia che volentieri lascio a menti più eccelse della mia.
Se dovessi individuare la sfida delle future indicazioni nazionali e dove puntare la loro barra, non avrei esitazioni a indicare la strategia del buon senso. Il che non si tradurrebbe in una improbabile sintesi (o, peggio, compromesso) tra competenzisti e contenutisti, tra disciplinaristi e pedagogisti, ma nel mettere le cose al loro posto, utilizzando senza remore quel buon vecchio “rasoio di Ockham” che, da parecchi secoli, ci insegna a sbarazzarci degli “enti inutili” e a non procedere alla trasformazione del semplice nel complicato attraverso l’inutile. Perché questo invece è accaduto in questi anni nelle fasi di passaggio tra riforme per lo più abortite.
L’ideologia del “competenzismo” e delle “teste ben fatte”, come tutte le ideologie, è andata ben oltre il segno. La lotta (giusta) contro il “nozionismo” ha portato a travolgere, caricaturizzando il sapere (la lezione imparata, come si diceva un tempo, a pappagallo), le stesse conoscenze che, per di più, solo un rigurgito neopositivistico può portare a finalizzare, sempre e comunque, a una utilità pratica. Il timore di essere scontati o banali ha indotto a spaccare la koiné educativa innanzitutto distruggendo una lingua comune tra insegnanti, famiglie, studenti; poi a procedere a una discutibilissima “amplificatio” retorica che porta a illustrare (male) in dieci pagine ciò che potrebbe essere detto (bene) in cinque righe; infine, in un delirio tassonomico, a pretendere di incardinare tra loro conoscenze, abilità, competenze in mirabolanti tabelle pluricolonna che dubito un insegnante prenderebbe mai sul serio nel proprio percorso didattico ed educativo.
PER CONTINUARE A LEGGERE L’ARTICOLO, CLICCA IL SIMBOLO ">>" QUI SOTTO
Compresi quegli “assi culturali” al termine del biennio dell’obbligo cui sarà forse il caso, a tempo e luogo, di rimettere mano, visto che, come ben sanno i membri di quella commissione, si trattava solo di una “prima bozza” che lo spazientito Fioroni trasformò in legge tagliando il nodo gordiano di un dibattito a suo dire protrattosi troppo a lungo. Il tutto condito dalla moda strutturalista sulla quale, in una formidabile palinodia, Tzvetan Todorov ha detto parole definitive. Insomma, rispetto a tutto questo, occorre procedere in una direzione contraria perché “l’abbassamento dei livelli” non è una preoccupazione per il domani, ma una realtà, drammatica, di oggi, come testimoniano le prove nazionali e internazionali, le valutazioni compiute dalle università sul livello di preparazione delle matricole e, buon ultimo, il grido d’allarme dell’Accademia della Crusca sul semianalfabetismo di una fetta consistente di popolazione.
Ritornare all’ordine e al buon senso significa, innanzitutto, fissare obiettivi fondamentali, raggiungibili, verificabili. Il che non vuol dire né abbassare (ulteriormente) l’assicella del sapere, né rifugiarsi in una comoda genericità. Significa, al contrario, indicare chiaramente cosa ci si aspetta alla fine del percorso educativo in termini di conoscenze, abilità, competenze portando l’accento (l’accento, non fiumi di inchiostro) su tutti tre i termini, collocandoli al loro posto e tornare a ragionare sui contenuti fondamentali delle discipline, sulle abilità proprie di ciascuna di esse e su quelle da considerarsi trasversali, sui profili in uscita generali e particolari, riassaporando il termine cultura. Significa verticalizzare e rendere tracciabili i curriculum, evitando le fratture tra i cicli scolastici e tra i cicli scolastici e l’alta formazione, universitaria o meno, ponendo fine allo sconcio di atenei costretti a ri-alfabetizzare le proprie matricole o a insegnanti di latino (i più tenaci) impegnati a spiegare cosa sia un accusativo a chi mai, nel proprio percorso scolastico, ha mai avuto sentore dell’esistenza di una certa analisi logica o grammaticale.
Significa favorire lo scambio di esperienze pedagogiche e negare diritto di cittadinanza a qualunque prescrittivismo pedagogico “di Stato”, perché la via per il successo educativo non è assimilabile al processo di fabbricazione di un tondino: passa attraverso una relazione educativa tra insegnante e studente che è irriducibile a schemi perché l’animo umano, le relazioni umane sono irriducibili a schemi. Significa mettere a regime il sistema di valutazione nazionale, che non può e non vuole essere ridotto a un “testificio”, ma che deve essere messo nelle condizioni di poter misurare e premiare il successo educativo, individuare le malattie affinché, passaggio non scontato, siano curate.