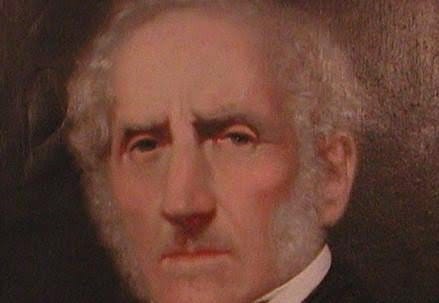“La mattina del 21 di giugno 1630, verso le quattro e mezzo, una donnicciola chiamata Caterina Rosa, trovandosi, per disgrazia, a una finestra d’un cavalcavia… vide venire un uomo con una cappa nera, e il cappello sugli occhi, e una carta in mano, sopra la quale, dice costei nella sua deposizione, metteva le mani, che pareua che scrivesse“. Così, con un movimento tutto cronachistico e narrativo, a riprova che il Manzoni storiografo è sempre formidabile narratore, inizia il racconto della Storia della Colonna Infame, il saggio storico sul processo agli untori durante la grande peste del 1630, che Manzoni volle pubblicare come appendice alla versione ultima dei Promessi sposi, detta “Quarantana”, uscita tra il ’40 e il ’42. Il tema era affiorato nei capitoli XXXI e XXXII del romanzo, dedicati interamente alla peste, dove Manzoni aveva annunciato “un nuovo lavoro”, da pubblicare a parte, per non appesantire ulteriormente il racconto di digressioni storiche che avevano attirato le dure critiche di Goethe. Nato come una costola dei Promessi sposi, l’autore desiderava che il testo della Colonna concludesse ogni edizione del romanzo; indicazione quasi sempre disattesa dai moderni editori, specie scolastici, del capolavoro manzoniano, sicché è possibile affermare che il trattato sugli untori sia in gran parte sconosciuto ai giovani, ed anche meno giovani, lettori. Eppure è risaputo che all’origine del romanzo vi sia l’attenzione destata dal processo agli untori, che l’autore e i suoi contemporanei non potevano certo fare a meno di collegare per analogia di ferocia con i processi dei primi anni ’20 contro i patrioti antiaustriaci, molti dei quali amici di Manzoni.
Il meraviglioso incipit che abbiamo citato introduce efficacemente i poli della vicenda: da un lato la casualità — la popolana che “per disgrazia” si affaccia alla finestra ad un’ora così insolita, dall’altro la responsabilità che la porta alla spontanea deposizione. Si ricordi che le testimonianze della Rosa e quella di un’altra “spettatrice”, mai veramente verificate, innescheranno un tragico meccanismo che condurrà all’orrenda uccisione di tanti innocenti.
La Storia della Colonna Infame non ebbe, al suo apparire, l’accoglienza che meritava: il pubblico, aspettandosi un nuovo romanzo, rimase deluso; i critici non accolsero con favore quel ripiegamento verso una fase della storia milanese che si voleva dimenticare per proiettarsi con più fiducia verso il futuro. Manzoni ebbe a soffrirne non poco. Scarse e per lo più negative le recensioni; pochissime le ristampe, e così è stato fino all’edizione curata da Vigorelli nel 1942, dopo la quale, finalmente, il trattato fu riportato alla giusta luce. Tuttavia, anche oggi, stenta a raggiungere un pubblico più vasto.
La passione per la verità costituisce il fil rouge di tutta l’opera manzoniana: dal proposito di non tradire mai “il santo Vero” dei giovanili versi per Carlo Imbonati, all’elaborazione della poetica del Vero, oggetto di tutta la sua ricerca letteraria .”L’ansia di conoscere il vero è la sola cosa che possa indurci ad attribuire importanza a ciò che apprendiamo”; al poeta “non domandiamogli che di essere vero”: “più si va addentro a scoprire il vero nel cuore dell’uomo, più si trova poesia vera”: sono celebri affermazioni dei suoi scritti teorici e nel romanzo aggiungerà: “ci basti aver dei fatti da raccontare”. Anche nella Colonna, dunque, assistiamo a un rigoroso percorso razionale: solo un corretto uso della ragione permette di conoscere la realtà. Manzoni è convinto che nessun fatto, per quanto apparentemente assurdo, possa sottrarsi all’investigazione della ragione. In questo senso, egli è pienamente illuminista e pienamente cristiano, in quanto porta a compimento l’eredità della riflessione del secolo dei lumi unendola al realismo della tradizione cristiana, specie in terra lombarda. Si inserisce in tal modo a pieno titolo sulla scia, a lui tanto familiare, di Beccaria e di Verri, incarnando, per così dire, una “via italiana” all’illuminismo, fatta di pragmatismo e di buon senso, come si sa ben diverso dal senso comune. Sicuramente l’indagine manzoniana deve molto al pamphlet Dei delitti e delle pene di Beccaria (1764) e soprattutto alle Osservazioni sulla tortura di Pietro Verri (1777), libro che si occupa specificatamente del caso degli untori: Verri fu il primo a riconoscere esplicitamente (un secolo e mezzo dopo i fatti!) le gravissime responsabilità dei giudici e a rendere giustizia al Piazza e al Mora, i due principali accusati. Tuttavia, sono evidenti i diversi approcci al caso di Verri e Manzoni; il primo è teso all’abolizione della tortura (effettivamente eliminata dall’ordinamento penale dello Stato di Milano nel 1784, anche per merito delle sue pagine) e attribuisce la ferocia del caso “all’ignoranza de’ tempi” e alla “barbarie della giurisprudenza”. Ma ciò non basta, secondo Manzoni, a spiegare “atti iniqui”, prodotti da “passioni perverse”. Tali passioni non possono essere eliminate con una legge. Eccoci dunque al cuore della riflessione manzoniana: il problema del male, connesso alla libertà e alla responsabilità umane. Affrontando un caso particolare, che diventa specimen dell’universale, Manzoni si inabissa nel vortice di “un gran male fatto senza ragione da uomini a uomini” e rimane abbagliato dal delirio collettivo della folla che, in preda a un furore maligno, grida il suo crucifige, e dal delirio dei magistrati, autori della massima, irreparabile ingiustizia. Eppure, era un’ingiustizia “che poteva esser veduta da quelli stessi che la commettevano, un tragredir le regole ammesse anche da loro, dell’azioni opposte ai lumi che non solo c’erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili mostraron d’avere”. Lo scoramento di fronte all’apparente vittoria del male aveva dettato ad Adelchi morente i versi famosi: “Una feroce/ forza il mondo possiede, e fa nomarsi/ Dritto…”. Davanti a tanto ingiustificato orrore praticato da uomini di legge che potrebbe parere “un sogno perverso e affannoso”, è un “sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell’ignoranza che l’uomo assume e perde a suo piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori”. Bisogna dunque fissare lo sguardo senza paura sul mysterium iniquitatis, sul cuore di tenebra dell’uomo, senza cadere nell’illusione che basti riformare le istituzioni per cambiare la società, ignorando che le buone come le cattive istituzioni, “non si applicano da sé”; occorre tener conto del “fattore umano”, esplorando l’abisso della libertà umana.
Nel Novecento, Eliot avrebbe denunciato l’eterna tentazione di sognare “sistemi talmente perfetti che nessuno più avrebbe bisogno di essere buono”. L’attenzione è dunque rivolta alla libertà e alla responsabilità degli uomini, sia quando si tratti di una moltitudine faziosa, sia di singoli rappresentanti della legge. Furono quei giudici che, assecondando la folle irrazionalità della massa, misero a morte degli innocenti, venendo meno ai loro doveri di magistrati e di uomini, agendo “contro ogni legge, contro ogni autorità, come contro ogni ragione”. Accecati da una funesta passione, “la smania di condannare” li privò “della facoltà di riflettere”. Essi infatti “non cercavano una verità, ma volevano una confessione”. Al centro dei Promessi sposi, la figura dell’Innominato è lì a ricordarci che il mondo è sotto l’impero del male, ma è sufficiente che il cuore di un solo uomo si converta perché tutto cambi.
L’acquiescenza ai pregiudizi pare allo scrittore la colpa più grave. “La vera ignoranza è quella intellettuale e morale di coloro che rinunciano alla ricerca della verità, alla giustizia, alla ragione, al loro dovere professionale e istituzionale per assecondare passioni umane perverse e pregiudizi” (Jacomuzzi).
E’ questo a rendere terribilmente attuale la Storia della Colonna Infame e a raccomandarne a tutti la lettura, come libro ancora oggi utile a leggere fenomeni discriminatori e violenti. Perché le ingiustizie contro gli innocenti non sono finite, e nemmeno le torture, e le ideologie, comunque camuffate, si ripresentano sulla scena a reclamare le loro vittime. Di fronte a ciò l’esercizio indomito della ragione che Manzoni propone non basterà ad abolire le “perverse passioni”, ma almeno varrà a renderle “meno potenti e meno funeste col riconoscerle ne’ loro effetti, e detestarle”.