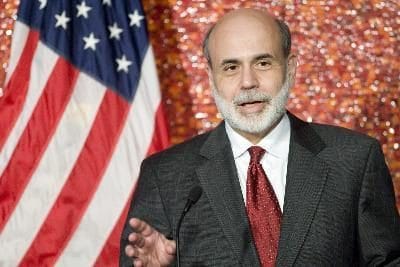L’appuntamento cardine della prossima settimana non sarà la tornata elettorale di mid-term negli Usa, bensì la riunione della Federal Reserve, simposio nel quale il comitato apposito deciderà se e come dare il via a una nuova ondata di quantitative easing, già denominata QE2. All’inizio i mercati hanno cavalcato la certezza di questo nuovo intervento statale nel mercato dei Treasuries, ma da qualche giorno a questa parte si scontano i timori riguardo una portata minore del preventivato, sia a livello di massa monetaria, sia di incisività nel settore obbligazionario.
Timori, questi ultimi, riposti, a ben vedere. Il grande punto di domanda, infatti, risiede proprio sul quantitativo di assets che la Fed dovrebbe acquistare per sortire l’effetto voluto. Al momento, la vulgata più accreditata è quella di un acquisto di assets per 500 miliardi di dollari spalmato su sei mesi, ovvero uno stimolo pari a quello di una riduzione di mezzo, tre quarti di punto del tasso dei fondi federali. Insomma, accettabile anche perché, dato che la Fed deve inoltre comprare 30 miliardi di Treasury al mese per reinvestire i repayments a breve dal suo portafogli di obbligazioni legate a mutui, sei mesi appaiono il tempo minimo necessario stante la cifra stanziata.
Ma cosa fare dopo questa mossa iniziale? Il Federal Open Market Committee (FOMC) potrebbe tranquillamente – e molto probabilmente lo farà – trincerarsi dietro la frase di rito «siamo preparati a porre in essere ulteriori misure se questo sarà necessario», di fatto prendendo tempo e spostando l’attenzione su riunioni future sperando che la situazione migliori. Ma perché questo miglioramento si registri, occorre che la Fed abbia ben chiaro cosa intende ottenere da questo nuovo programma di QE2 e quanto quest’ultimo debba essere ampio per sortire l’effetto sperato.
Attualmente, questa chiarezza non c’è. Dovremo aspettare mercoledì prossimo, quando le quattro paginette di documento ufficiale redatte dal FOMC dovrebbero schiarire l’orizzonte, ma per ora ci dobbiamo accontentare del calcolo fatto da Jan Hatzius di Goldman Sachs, il quale – utilizzando la cosiddetta “Taylor rule”, basata sui cosiddetti “output gaps” e che imporrebbe, teoricamente, agli Usa tassi al -7% in questa contingenza di stimolo – ha reso noto in un report dal titolo “QE2: How much is needed?” che per ottenere l’effetto di stimolo sperato occorrerebbe un QE2 da 4mila miliardi di dollari e acquisti di assets per 2mila miliardi.
Alla Fed lo sanno, ma si guardano bene dal dirlo, visto che non hanno risposto nemmeno alle critiche avanzate da critici meno feroci riguardo costi e rischi del programma, dalla difficoltà nel dover eventualmente vendere gli assets comprati al rischio di distorsione del mercato dei Treasuries fino al periglio politico di un vagabondaggio nella politica fiscale. Inoltre, a mio avviso, esiste il rischio che i benefici potenziali del QE2 crolleranno e i costi aumenteranno se questo crescerà di volume e portata. Inoltre, il principio di connessione meccanica tra QE2 e l’enfasi data recentemente dalla Fed all’obiettivo di contenimento dell’inflazione sotto il 2% non garantisce affatto che la Federal Reserve amplierà automaticamente il volume del QE2 per tutto l’arco temporale in cui le previsioni garantiranno un tasso inflattivo sotto il 2%. Insomma, poche certezze, se non quella che con un QE2 iniziale di 500 miliardi di dollari la Fed punterebbe a far coincidere il suo impegno duale, ovvero bassa inflazione e occupazione sostenibile.
Ma qual è il reale mandato, quello statutario, della Fed? “Promuovere effettivamente gli obiettivi di massima occupazione, prezzi stabili e tassi d’interesse moderati sul medio termine”. Peccato che prezzi stabili non siano la stessa cosa di bassa inflazione, visto che ci vuole la maniacale ossessione di Ben Bernanke per la dottrina del target inflazionistico per tramutare questo mandato nello stampare larghe somme di denaro nel momento stesso in cui le misurazioni annuali sull’inflazione della Fed di Dallas sono salite dallo 0,5% di maggio, allo 0,8% di luglio fino all’1,5% di agosto. Ma abbandoniamo queste contestazioni teoriche e torniamo al vile denaro, che alla fine dovrebbe raggiungere comunque i 2 trilioni di dollari nel totale del programma di QE2.
Il fatto è che, a differenza di quanto accadde durante il primo programma di QE, oggi non ci troviamo più in una crisi finanziaria di sistema e le motivazioni della Fed che sottendono la nuova mossa sono non più accettabili in toto. Avendo dichiarato che non è affare delle banche centrali fermare le bolle degli assets – specificando che il fall out dell’esplosione poteva essere pulito dopo in maniera sicura -, ora Bernanke intende avvalorare questa assurda dottrina unendo tutte le forze del sistema economico e finanziario Usa a questo fine.
Un errore dopo l’altro, il primo teorico, il secondo – purtroppo – pratico. Il primo QE, infatti, funzionò: stabilizzò la massa monetaria M3, la misura della massa M2 – che ancora a maggio 2009 si stava contraendo – è continuata a crescere a tasso annuale dell’8,4% dalla metà di ottobre e il passo dell’accelerazione è cresciuto per mesi. Un tasso simile non è Weimar ma nemmeno la deflazione più nera. E che dire della velocità, ovvero l’altra parte del cocktail monetario posto in essere dalla Fed con il primo QE? Stando alle misurazioni di Simon Ward della Henderson Global Investors, la velocità sta aumentando con un tasso molto robusto dell’8,7%: «Il primo QE era giustificato nel corso della crisi poiché la velocità monetaria stava collassando. Ma ora la velocità sta recuperando bene e quindi non c’è necessità di un nuovo QE. In effetti, questa ipotesi è potenzialmente molto pericolosa»
Infatti, a oggi, l’effetto immediato della retorica Fed riguardo il QE2 è stato quello di portare un rialzo del prezzo delle commodities, negativizzando molti dei benefici. «Come una scelta simile possa aiutare un’economia moribonda come quella Usa è la domanda che tutti quanti si stanno ponendo», è l’amara analisi di David Rosenberg della Gluskin Sheff, secondo cui «se esiste uno sbilanciamento, questo risiede nella pretesa degli Usa di risolvere problemi strutturali, bilanci fuori controllo, disoccupazione cronica e crisi immobiliare con strumenti di politica della Fed mai provati».
A difesa parziale della Fed c’è da dire che non è del tutto peregrino essere preoccupati per una protratta deflazione, potenzialmente letale in un’economia con il totale del debito al 350% del Pil: chi invoca politiche liquidazionistiche di bancarotte e default di massa rischia oggi di fare più danni della stessa politica di Ben Bernanke, il quale però sta commettendo il peccato originale di non voler accettare la realtà, ovvero che gli Usa debbano passare attraverso un lenta e dolorosa cura di develeraging del debito e non possano vedere spazzati via con manovre come il QE2 vent’anni di creazione del debito e di errori della Fed.
Da oggi in poi, la Federal Reserve dovrà navigare tra la Scilla della deflazione e la Cariddi dell’inflazione, per anni, per quanto serve, fino a quando l’America non avrà debitamente purgato il suo sistema. Ma passando da un eccesso all’altro, paradossalmente, troviamo l’Europa del debito.
Se infatti l’America rischia di aggravare la sua crisi per un eccesso di denaro e liquidità, l’eurozona rischia l’effetto contrario del desiderato per un abuso di austerità e rigore. Questa settimana in Portogallo sono falliti i colloqui per giungere a un accordo bipartisan sulla manovra d’emergenza, uno stop che ha fatto dire al ministro delle Finanze, Fernando Texeira dos Santos, che un fallimento dei negoziati sui tagli al budget «potrebbe gettare la nazione in una vera e profonda crisi finanziaria». Nel contempo, l’Irlanda ha annunciato un’ulteriore contrazione fiscale per 15 miliardi di euro nei prossimi quattro anni, a fronte di tagli agli stipendi pubblici del 13% già in atto.
Per John Fitzgerald dell’Ireland’s Economic and Social Research Institute «c’è il forte rischio che l’austerity getti l’economia in una spirale ribassista, una sorta di overdose di chemioterapia che fa più danno che utile». E la Grecia? I rendimenti sulle obbligazioni decennali sono saliti di 67 punti base al 10,26%, il salto in avanti più grande dalla crisi di giugno. A scatenare il sell-off, le dichiarazioni del premier George Papandreou, il quale ha avvertito che «la nazione è ancora in pericolo», paventando subito dopo la possibilità di indire elezioni anticipate.
Il ministro delle Finanze, George Papaconstaninou, si è rifiutato di bocciare a priori la richiesta per un’estensione del periodo concordato per ripagare il pacchetto di salvataggio Ue, confermando che le entrate fiscali stanno crollando e raschiando il fondo: «Stiamo deludendo noi stessi come nazione pensando di avere un sistema di tassazione. Non lo abbiamo», ha dichiarato. Inoltre, ha confermato che il deficit di budget per il 2009 potrebbe essere al di sopra del 15% del Pil, ben più in alto della precedente previsione del 13,8% e cinque volte quella del 3% fatta dal precedente governo (che, parere personale, andrebbe incriminato in blocco per bancarotta fraudolenta).
Per Gavan Nolan di Markit, azienda che monitora i valori dei cds, «le paure per le instabilità politiche nei crediti sovrani stanno tornando al centro degli schermi radar, con investitori che ora prestano moltissima attenzione alle mosse, possibili e non, dei governi per quanto riguarda i piani di austerità». Riusciranno questi paesi a utilizzare l’export per uscire dalla crisi oppure resteranno intrappolati in questa situazione, con ovvie e crescenti tensioni politiche e spread impazziti a rendere i loro debiti ancora più pesanti? Difficile dirlo, l’Irlanda forse può farcela ma per Portogallo, Spagna e Grecia la strada si sta facendo davvero stretta.