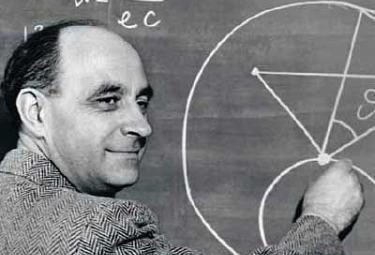La lettura dell’articolo di Claudio Gentili mi ha lasciato di sasso. Lo prego quindi, se non gradirà la mia replica, di chiedersi se la causa non risieda nel tono aspro – nei confronti di noi, rimasti ai tempi in cui Berta filava, fabbricanti di dotti destinati a diventare furfanti – e nella sequela di asserzioni propinate con cattedratica arroganza intellettuale.
Su che basi, poi? Nel leggere la definizione di matematica proposta da Gentili mi chiedevo: ha egli mai riflettuto a cosa sia la matematica e cosa sia un oggetto matematico? Ha studiato la differenza tra approccio classico e modellistica? Ha mai praticato la matematizzazione? Sa qual è la differenza tra matematica pura e applicata e si è mai chiesto se abbia senso? Conosce la storia della matematica? Chiaramente no. Egli dirà di essersi limitato a riferire una definizione dell’OCSE. Ma quando si propinano con tanta sicurezza le definizioni altrui bisogna essere in condizione di difenderle da chi, con “competenza”, le considera un ridicolo tessuto di false banalità, tipico prodotto di un triste gergo cultural-burocratico. Altrettanto dicasi della definizione di “literacy scientifica”, inutile conglomerato di tautologie o di ovvietà tanto ovvie da essere prive di senso. Cosa può fare di simili definizioni vuote un insegnante, un vero insegnante, uno che lavora sul campo, che conosce quali domande fanno gli studenti, quali problemi si pongono?
L’ha detto l’OCSE… E figurarsi… Non se ne può più di questa subcultura burocratica che rifà la storia della cultura a suo uso e consumo, del genere della trovata secondo cui le università medievali andrebbero prese a modello di una fucina di saperi artigianali e pratici. Come se non fossero state soprattutto grandi centri di elaborazione teorica che hanno dato un apporto alla costituzione della meccanica a partire dalla teologia e dal ripensamento di Aristotele.
Ci troviamo di fronte alla tipica fenomenologia che ha condotto al disastro dell’istruzione a livello europeo, come sempre più viene riconosciuto. E cioè alla presenza di una corporazione di “esperti” scolastici che, pur privi di competenze specifiche, ritengono di dettar legge in nome di una fumosa dottrina metodologica dell’“education”. È una dottrina concentrata attorno alla defatigante quanto sterile produzione di definizioni di “conoscenza”, “competenza” e “abilità”, ormai simile a una scolastica tardo-medievale che ricorda il detto «quando la storia si ripete è sempre in farsa». È il possesso di questa dottrina – ormai unica disciplina che conserva il diritto alla trasmissione cattedratica – che fa credere di essere titolati a inanellare autentiche assurdità da matita blu, come quella secondo cui «tempo, energia e misura si possono apprendere solo integrando le diverse discipline scientifiche».
Clicca >> qui sotto per continuare l’articolo di Giorgio Israel
Apprendere il tempo?… Ma che vuol dire? Di certo, Gentili cosa sia la misura non l’ha appreso, visto che parla di “competenza misurabile”. Non starò qui ad annoiare il lettore esponendo tutti i requisiti richiesti affinché una grandezza possa dirsi misurabile. Molte cose sono suscettibili di rappresentazioni quantitative: per esempio, quando si da un voto a scuola si descrive in numeri una valutazione qualitativa e che resta tale malgrado i numeri; ma non si misura assolutamente nulla. Neppure la temperatura era una grandezza misurabile prima dell’avvento della termodinamica, figuriamoci la competenza. Ogni qualvolta che qualcuno mi parla della misurazione delle competenza chiedo quale ne sia l’unità di misura e, ovviamente, non c’è mai risposta. Le persone serie per lo più ammettono che si tratta di un’idea priva di fondamento. Ma c’è gente che – nel quadro di quella gigantesca mistificazione che è l’idea della “misurazione delle qualità” – continua a dilettarsi di queste speculazioni che, anch’esse, richiamano quelle dei “calculatores” del tardo medioevo che cercavano persino la misura del peccato e della grazia.
Insomma, non esiste il diritto di valutare le nuove Indicazioni nazionali sulla base di una metascienza dell’istruzione, la cui consistenza è tutta da dimostrare, e da valutare. Non esiste la legittimità di una metascienza indipendente – si passi il gioco di parole – da ogni conoscenza, competenza e abilità specifiche. Ribadisco che il vero male dell’istruzione è il trionfo della metodologia pura, le discettazioni infinite alla don Ferrante su “teste vuote” e “teste piene”, la dittatura di metodologi che nella maggior parte dei casi non hanno mai messo piede in una classe.
Gentili propone una fallace contrapposizione tra Leibniz («la cultura libera dal lavoro») e Spinoza («ogni uomo dotto che non sappia anche un mestiere diventa un furfante»), per contrapporre il disciplinarismo delle nuove Indicazioni nazionali alla didattica delle competenze. Leibniz e Spinoza si sarebbero facilmente accordati per spiegargli che le loro visioni non sono affatto contrapposte e si richiamano alla grande tradizione della paideia greca. A Gentili consiglierei inoltre di approfondire la conoscenza di Spinoza, la cui filosofia della natura è quanto di più deduttivista si possa immaginare. Molto più di Galileo, che pure definiva la sua fisica come “matematica purissima”. Un buon “coaching” in storia della scienza non guasterebbe per spiegare che il successo della scienza occidentale sta proprio nell’aver preferito all’approccio empiristico il metodo sperimentale guidato dalla teoria (è chiaro che empirismo e sperimentalismo sono cose diversissime?). È una concezione ben riassunta dal motto di Leonardo da Vinci: «Studia prima la scienza, e poi seguita la pratica, nata da essa scienza. Quelli che s’innamoran di pratica senza scienza son come ‘il nocchier ch’entra in navilio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada».
Clicca >> qui sotto per continuare l’articolo di Giorgio Israel
Roba da Berta che filava? Di certo, l’empirismo è roba da Checco e Nina. Già ai tempi di Berta si sapeva benissimo che una teoria che non si accompagni alla capacità di applicarla e svilupparla è frutto di pessimo insegnamento.
«L’insegnante non trascurerà di sottoporre a osservazione o a esperimento la previsione, cui sarà pervenuto col ragionamento, per constatare se essa corrisponda alla realtà […] Gli alunni siano sempre attivi, trovino da sé, sotto la guida del professore, e non ricevano da lui solo direttamente il sapere bello e formato. Essi, entro certi limiti, devono ripetere per proprio conto e per vie abbreviate, il lavoro compiuto dalle passate generazioni nella conquista del sapere scientifico. […] non si dimentichi mai che si sa bene solo quello che si sa fare o applicare. […] Non esiste un metodo assolutamente buono, cioè egualmente efficace per tutti gli insegnanti; del pari non esiste un programma egualmente buono per tutti gli insegnanti. Ond’è che a ciascuno s’intende data libertà di sostituire qualche autore e di togliere o aggiungere qualche libro, che egli giudichi più utile al fine educativo […] Ciascun insegnante, entro certi limiti, deve avere libertà didattica e questa esercitare giudiziosamente e discretamente».
Questo si scriveva nel R. D. istitutivo dei licei “moderni”, nel 1913, ai tempi di Berta, quando erano ignote competenze, abilità, autoformazione e altre chincaglierie mentali. Fin dai tempi di Berta i miei buoni insegnanti mi hanno spiegato le stesse cose: gli altri costringevano a passare pomeriggi risolvendo migliaia di radicali ed equazioni particolari. All’università un professore dei tempi di Berta mi consigliò di studiare così: cerchi sempre di risolvere problemi, non apprenda mai passivamente un teorema, ma provi con tutte le forze a dimostrare che è sbagliato. In realtà, fin dai tempi di Berta si sapeva benissimo che chi non sa fare e applicare in realtà non sa niente. Si badi bene: non si dice che possiede conoscenze ma è privo di competenze. Semplicemente non sa nulla. Una persona che conosca astrattamente un concetto e non lo sappia usare è un perfetto ignorante, al pari di uno che applichi meccanicamente delle regole senza avere la minima idea della loro base concettuale.
Clicca >> qui sotto per continuare l’articolo di Giorgio Israel
Il tentativo di porre rimedio al cattivo insegnamento creando una suddivisione artificiale tra conoscenze e competenze ha prodotto più guasti che rimedi cristallizzando una contrapposizione in termini ontologici. Altro che guardare alle “migliori esperienze” estere. I sistemi dell’istruzione europei sono, quale più quale meno, un cumulo di rovine. Si leggano i libri e i saggi di Laurent Lafforgue, Catherine Krafft, Liliane Lurçat, Alicia Delibes e tanti altri, senza contare le numerosissime testimonianze di insegnanti raccolte in articoli, libri, scritti vari anche in rete. Con quale diritto il pedagogismo delle competenze, la didattica cognitivista, le teorie olistiche, le strampalate teorie di Edgar Morin sull’insegnamento della complessità, e via discorrendo, possono sottrarsi a un giudizio dopo aver dominato incontrastati per anni e anni e addirittura pretendono di continuare a pontificare la loro scolastica come se nulla fosse?
Le nuove Indicazioni nazionali non si basano su una rivalutazione delle conoscenze contro le competenze. Nulla di tutto ciò. Esse superano questa sterile contrapposizione tornando al buon senso, a un uso corretto dei termini e, nella fattispecie, all’uso del termine “competenza” secondo il vocabolario della lingua italiana di Aldo Duro: «idoneità e autorità di trattare, giudicare, risolvere determinate questioni». Tantomeno mirano al nozionismo. Esse mirano a escludere sia ogni approccio meramente empiristico e praticone sia ogni approccio meramente teorico. Ma rivendicano, rigore, serietà: sui contenuti dei saperi non si scherza, non vi deve essere più posto per dilettantismo e chiacchiere. Inoltre rivendicano cultura e interdisciplinarità, come ben mostra l’originale presentazione per la matematica e la fisica.
Pertanto, a coloro che dicono che è ora di smettere una contrapposizione del tipo guelfi contro ghibellini tra “competenzisti” e “disciplinaristi” non si può che rispondere positivamente. A condizione di farlo per davvero, uscendo definitivamente dalle diatribe scolastiche. In altri termini, d’ora in poi si dovrebbe parlare dei contenuti – come e cosa insegnare di matematica, di letteratura italiana, di storia, ecc. – e mai più essere costretti a scrivere articoli come questo. Su queste basi si potrà andare avanti senza sterili contese. Il problema è che nel carro ormai malandato di un certo pedagogismo c’è anche chi non ha alcuna voglia di cessare le ostilità o lo vuol fare a condizioni leonine.
Anche se le funzioni del sistema dell’istruzione travalicano di molto quella di preparare tecnici aziendali, il rapporto tra scuola e mondo della produzione non può che essere un fattore altamente positivo e di grande vitalità. A condizione che quel mondo e la sua espressione confindustriale si avvicini al mondo dell’istruzione (penso anche all’università) con discrezione, modestia e senso dei propri limiti. Le cose si fanno invece molto difficili se si pretende di spiegare come deve essere inteso lo scibile e di dettare direttive in modo imperativo e polemico, nello stile “spada di Brenno”. Tra l’altro, Brenno non riscosse un gran successo.