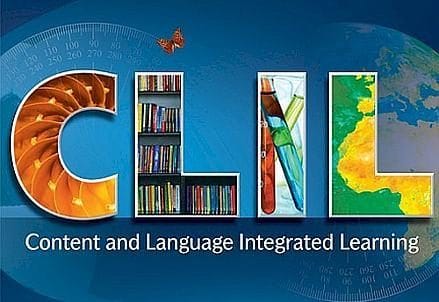Un acronimo, dietro cui si nasconde un’operazione che sta entrando in modo strisciante nelle scuole secondarie di secondo grado, in primis nei licei linguistici; con il rischio di compromettere sia l’apprendimento disciplinare sia quello della lingua inglese.
L’eliminazione della lingua madre nell’insegnamento delle discipline scientifiche, per esempio la fisica, la chimica e la biologia (considerate appartenenti alla categoria delle non linguistiche – DNL), ne ignora la portata formativa sul piano logico-argomentativo. Con un inevitabile impoverimento in tempi più o meno brevi dell’insegnamento/apprendimento scientifico sul piano linguistico e quindi concettuale.
Se oggi una reale conoscenza dell’inglese o di altra lingua straniera è indispensabile a scopi di studio e di lavoro, appare rischioso risolvere il problema del bi-(o pluri)-linguismo applicando tout court un modello metodologico che appare fondato su un malinteso processo di internazionalizzazione.
Il contributo che segue offre alcune essenziali riflessioni su cui il mondo della scuola dovrebbe incominciare a interrogarsi.
In relazione al cosiddetto CLIL – o «apprendimento integrato di lingua e di contenuti» – mi sembra opportuno che si tengano presenti alcune dimensioni: (1) l’ambito specifico; (2) la lingua impiegata per denotare unità e processi dell’ambito specifico; (3) la costruzione del discorso secondo caratteri congrui; (4) la relazione educativa fra insegnante e allievi.
Per la costruzione di caratteri congrui (3) occorre tenere presente: (3.1) l’ambito specifico; (3.2) le conoscenze ritenute pertinenti; (3.3) la tradizione del discorso che storicamente in una data comunità si è svolto e si svolge intorno a quell’ambito scientifico.
Mi sembra che le competenze del docente della materia siano decisive soprattutto per i punti 1, 3.1., 3.2. e 4. e che le competenze del docente di lingua siano decisive soprattutto per il punti 2., 3.3. e 4.
Come si vede, a entrambi sono richieste competenze ed esperienze solide nel punto 4, che a mio avviso denota un rapporto pedagogico-antropologico. E’ infatti una relazione interpersonale costitutiva dell’esperienza umana la comunicazione fatta per aiutare il destinatario a vedere, a riconoscere la realtà e a fare ipotesi sulla realtà nel rispetto delle caratteristiche della realtà.
Vi sono alcuni aspetti problematici, che l’esperienza del docente può certo contribuire a risolvere, in parte o nel complesso, ma che rischiano di pregiudicare l’apprendimento sia delle materie sia della lingua impiegata.
Primo problema: la relazione educativa fra insegnante e allievi
È lecito ritenere che la comunicazione didattica e l’organizzazione del sapere vengano pregiudicate dall’uso di una lingua che non sia pienamente dominata sia dal mittente sia dal destinatario. Può risentirne anche l’interazione docente-allievo.  Nella fase di «immagazzinamento» delle conoscenze, i concetti e le proposizioni del sapere scientifico sono appresi e fatti propri come contenuti organizzati grazie alla lingua (la scienza è discorso che esprime i contenuti della scienza).
Nella fase di «immagazzinamento» delle conoscenze, i concetti e le proposizioni del sapere scientifico sono appresi e fatti propri come contenuti organizzati grazie alla lingua (la scienza è discorso che esprime i contenuti della scienza).
L’organizzazione cognitiva e le operazioni cognitive essenziali per fissare i contenuti hanno bisogno di una lingua dominata in modo adeguato da chi apprende, tanto più che, nella scuola, gli allievi imparano anche a imparare.
In una fase così delicata per l’elaborazione e lo sviluppo anche delle metodologie di apprendimento, può una lingua straniera (una «L2», dicono gli esperti) conosciuta in modo superficiale o incompleto servire per organizzare cognitivamente il sapere, per interrogarsi e porre domande, per trovare soluzioni? È lecito nutrire qualche riserva.
Per molti allievi, anche la L1 – la prima lingua – può essere in parte «straniera», dato che il discorso «professionale» a scuola si svolge secondo un registro linguistico più freddo di quello familiare; del resto, è noto che un freno all’apprendimento è dato a volte proprio dalla scarsa capacità degli allievi di dominare la variazione diafasica cioè la differenza nelle modalità espressive – usando a scuola uno stile più formale rispetto a quello familiare o trascurato, proprio della comunicazione fra amici o fra «pari grado».
Peraltro, si tratta qui forse di situazioni riscontrabili soprattutto in contesti di disagio di vario genere, ma correggibili nella pratica scolastica.
Secondo problema: le tradizioni didattiche dell’insegnamento delle scienze
Nella tradizione italiana le scienze «deduttive» come la matematica e le scienze naturali sono insegnate, appunto, secondo la struttura della deduzione. Per esempio, si danno prima i teoremi e la loro dimostrazione; seguono applicazioni, che servono per illustrare il teorema. Oppure si dà prima una legge generale, cui segue l’applicazione della legge generale.
Altre tradizioni didattiche, in particolare quelle di matrice inglese (UK, USA, eccetera) ricorrono a un approccio induttivo – dal caso particolare si conclude a una legge generale. L’uso dell’inglese è anche uso del discorso secondo la tradizione didattica dei Paesi di lingua inglese. Di questo è opportuno tenere conto, a proposito di CLIL.
Vi è qualche ragione nel ritenere che sia riduttivo limitarsi a rivestire di termini inglesi un discorso costruito secondo i criteri tradizionali impiegati nella comunicazione scientifico-didattica in Italia; bisogna anche comunicare «in prospettiva» anglofona, cioè costruire il discorso (la descrizione, la spiegazione, l’argomentazione, eccetera) secondo i moduli della tradizione testuale propria della cultura anglo-sassone e/o anglo-americana.
Non basta tradurre i termini; occorre ricalibrare le forme della comunicazione, trovando quelle congrue con le tradizioni scientifico-culturali del discorso «anglofono». Non è gran cosa tradurre in inglese un contenuto già organizzato secondo la tradizione testuale della comunicazione didattico-scientifica italiana: è come preparare una pietanza inglese senza saperne amalgamare gli ingredienti nel modo adeguato (o, il che è lo stesso, è come fare la pizza senza saperla fare, pur usando i giusti ingredienti).
A soffrire è la tradizione didattico-scientifica italiana, ma è anche l’inglese, che non è più inglese, ma un ibrido – uno dei tanti ibridi in giro per il mondo. Si opera un deleterio straniamento, perché manca il contesto proprio del discorso in inglese – manca cioè l’«ambiente», l’humus scientifico-culturale adeguato alla comunicazione in inglese. Non si impara inglese in questo modo. E non si impara neppure una disciplina.
L’insegnante «facilitatore» Negli ultimi anni è dato incontrare – e in Italia e all’estero – una abitudine d’insegnamento poco pedagogica: l’insegnante (il «facilitatore») si limita a portare esempi, affidando agli allievi il compito di riconoscere analogie fra i casi descritti. |
Terzo problema: la forma interna delle espressioni usate come termini delle scienze
Non è, quest’ultimo, un problema cruciale per l’apprendimento scolastico. Si tratta, più che altro, di una difficoltà avvertita soprattutto da chi abbia interesse a capire la lingua. Ed è lecito ritenere che non pochi studenti delle superiori nutrano vivo interesse per una lingua e per la cultura che prende forma in quella lingua.
Nella prospettiva che privilegia l’insegnamento «in lingua» dei contenuti scientifici, emerge l’interesse per la terminologia legata all’ambito scientifico. Vale tacitamente l’assunto per cui i concetti delle scienze naturali e delle matematiche sono universali, cioè che i loro contenuti non sono sensibili al cambiamento della lingua. Molto bene. Questa ipotesi è avvalorata da molte verifiche.
Però avviene che una lingua esprima un concetto usando una parola che si usa anche in altri sensi. Si ha così un termine scientifico (che serve per il concetto) e una parola vaga (cioè indeterminata) per il senso, che si trova nel discorso quotidiano. Per esempio, la parola italiana angolo serve in geometria, ma anche nell’uso quotidiano: angolo in «angolo di una stanza» non ha lo stesso senso che in «angolo acuto», «angolo ottuso» eccetera. In tedesco, l’angolo di una stanza è una Ecke; l’angolo acuto è un Winkel (spitzer Winkel). Com’è chiaro, un termine scientifico va tenuto distinto dall’uso che si fa della stessa parola nella lingua considerata.
Spesso, tuttavia, una parola serve, in una lingua, per denotare più concetti, persino nello stesso ambito. Pensiamo a lato: il concetto di «lato di un poligono» è identico al concetto «lato di un angolo»? La parola è la stessa; e siccome è la stessa, spesso non si riflette sul suo diverso uso; ma in tedesco (cito questa lingua, ma si possono portare esempi svariati di altre lingue) il lato dell’angolo si chiama Schenkel (per esempio Schenkel eines stumpfen Winkels, «lato di un angolo ottuso»), mentre il lato di un poligono si dice Seite (per esempio: die Seiten eines Vierecks, «i lati di un quadrilatero»). Tra l’altro, Schenkel è legato etimologicamente al greco skélos «gamba, lato» che troviamo nell’italiano isoscele; ma in tedesco un triangolo isoscele è detto gleichschenkliges Dreieck: per denotare i due lati uguali si usa cioè l’elemento – schenklig – che è legato a Schenkel, cioè al «lato» dell’angolo.
La situazione è confusa linguisticamente; essa non sembra influire sul modo in cui un tedesco conosce la geometria del triangolo (ma è davvero così? Servirebbero ricerche approfondite).
A volte, poi, le parole – anche quelle usate per i termini delle scienze – presentano implicitamente una «chiave di lettura» della realtà denotata: è una lettura che traspare dalla struttura lessicale e non è pertinente per la struttura concettuale, ma è interessante per la «storia sociale» della parola. Per esempio in italiano poligono significa «che ha molti angoli»: –gono viene da una voce greca che apparteneva alla famiglia di góny (genitivo gónatos) che significava «ginocchio»: si vede che per gli antichi la piegatura del ginocchio era l’esempio migliore per illustrare l’angolo.
Questo fatto è interessante linguisticamente, non è tuttavia pertinente nella costruzione del concetto geometrico. È poi interessante notare che l’elemento –gono si presenta per i poligoni con cinque lati e oltre. Invece, triangolo e quadrangolo riprendono direttamente la forma italiana –angolo; vi sono anche trilatero e quadrilatero.
Altre lingue sono più regolari e formano le parole con lo stesso schema: per esempio il tedesco usa –eck in corrispondenza di –gono (da Dreieck «triangolo» e Viereck «quadrilatero» a Zwölfeck «dodecagono»). Del pari, non è pertinente per il concetto di poliedro sapere che la parola poliedro contiene l’elemento greco hédra «faccia» – non è pertinente, ma è interessante per la comprensione della lingua e della storia culturale.
A questo punto viene da chiedersi se tutte queste osservazioni, che non riguardano la geometria, siano in qualche misura interessanti per cogliere quel sottile «mondo di mezzo», fra la realtà e l’individuo, che è costituito dalla lingua come «quadro» della realtà (sia osservabile sia non osservabile).
Ma chi potrà guidare gli allievi nella scoperta di questa dimensione?
Forse l’insegnante di matematica e geometria?
Forse l’insegnante di lingua?
Giovanni Gobber
(Ordinario di Glottologia e Linguistica presso l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano)
© Pubblicato sul n° 48 di Emmeciquadro